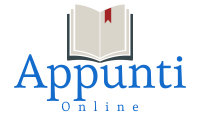L’ablativo assoluto si stabilizza come costrutto verbale nel I secolo a.C., e in origine è un costrutto nominale, sintagma composto da un nome o un pronome e un aggettivo al posto del quale è utilizzato un participio nella maggior parte dei casi, ma sempre in funzione aggettivale. Le funzioni da esso svolte erano eterogenee, ma la prevalente è quella strumentale sociativa. Es. dux preda capta Romam rediit; traduzione con il costrutto verbale: il generale tornò a Roma dopo aver conquistato il bottino; traduzione con il costrutto nominale: il generale tornò a Roma con il bottino conquistato. Es.: M. Messala M. Pisone consulibus coniurationem nobilitatis fecit; qui la funzione dell’ablativo è locativa, non è ellittico ma situa l’avvenimento della reggente in un momento, è un ablativo assoluto nominale, e si traduce come tale: egli sotto il consolato di Marco Messala e Marco Pisone fece una congiura della nobiltà. Quando si stabilizzò il costrutto verbale si fissarono anche due caratteristiche dell’ablativo assoluto: la mancanza di riferimenti ad esso nella reggente e l’alterità di soggetto. Quest’ultima è la più costante dal punto di vista statistico, si ha identità di soggetto solo con alcune locuzioni formulari cristallizzate come me consule, te invito, se absente. Esempio Livio: se iudice nemo nocens absolvitur: nessun colpevole si assolve sotto il giudizio della propria coscienza. Questo esempio prova anche che il costrutto può non essere passivo, come è invece in questo caso: Caesar recepto Norico Apolloniam reducit. La prima caratteristica è meno costante, infatti sono spesso presenti riferimenti specie pronominali all’ablativo assoluto nella sovraordinata, e di frequente sono contenuti nell’ablativo assoluto pronomi che hanno un proprio referente nella proposizione sovraordinata. Galba missis ad eum legatis constituit… Galba, dopo che gli furono mandati ambasciatori, decise… Il primo caso si riscontra spesso in Cicerone, Livio e Sallustio. In primo luogo ciò avviene per chiarezza. Esempio Cesare: Caesar obsidibus imperatis hos Haeduis custodiendos tradit. Cesare, ordinati degli ostaggi, li dà da custodire agli Edui. Il legame sintattico cui ci si riferisce è hos, che richiama obsidibus, raro specialmente in Cesare come in Tacito; ciò avviene per chiarire che proprio gli ostaggi sono consegnati agli Edui, la sua assenza avrebbe provocato ambiguità, sostantivando il gerundivo esso si sarebbe riferito ad altre persone. Altro motivo dell’uso di un legame simile è connotativo, una ricerca di simmetria. Esempio Cesare: Cognito Caesaris adventu, Ariovistus legatos ad eum mittit. Appreso l’arrivo di Cesare, Ariovisto gli manda ambasciatori. Il legame è ad eum, si vuole sottolineare una dimensione di azione e reazione, un bilanciamento degli eventi descritti, del loro rapporto di causa ed effetto. Un terzo motivo è la ricerca di enfasi. Esempio Cicerone: sese hoc incolumi non arbitrabatur huius innocentis patrimonium posse obtinere. Vivo costui non pensava di potersi impadronire del patrimonio di quest’onest’uomo. L’enfasi è giocata sull’esclusione di elementi tra subordinata e reggente: il soggetto della sovraordinata ha l’avida volontà di impadronirsi del patrimonio, la subordinata contiene la condizione che lo impedisce, la vita dell’uomo onesto. Questa volta il riferimento non è dato da un pronome ma da un intero sintagma, huius innocentis, ed il soggetto di principale e subordinata oggettiva è enfatizzato anche dal pronome riflessivo raddoppiato sese. Soprattutto le ultime due motivazioni si intrecciano e non sono sempre ben distinguibili.